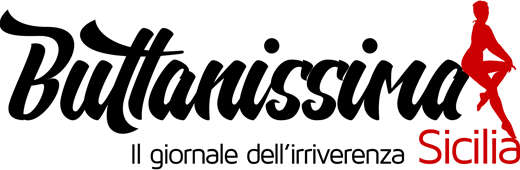Era tutto già scritto. Almeno da venticinque anni, da quando la Sicilia conobbe la sua prima emergenza idrica. La Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione, ha messo nero su bianco – in una relazione di 224 pagine – che i problemi di oggi sono figli di un’irrisolta gestione dell’acqua, aggravata da un sistema infrastrutturale vetusto e frammentato. «I mutamenti climatici – scrivono i relatori Salvatore Pilato e Marina Segre – avrebbero dovuto indurre la Regione al miglior governo dell’approvvigionamento idrico, che viceversa è diventato meno sicuro».
I numeri parlano da soli: il 52% dell’acqua immessa in rete si perde, con punte del 75% nella provincia di Catania, del 68% a Siracusa e del 58% a Ragusa. E il paradosso è che il 75% dell’acqua che entra nelle condotte siciliane non viene pagata da nessuno, tra perdite fisiche, allacci abusivi, utenze senza contatore e morosità dilagante. I magistrati contabili rilevano anche un episodio degno di un romanzo kafkiano: buona parte della documentazione relativa alla gestione emergenziale 2001–2006 è sparita perché l’archivio in cui era conservata si è… allagato. Nel frattempo, 45 dighe garantiscono solo due terzi del loro potenziale, con 7 invasi fuori esercizio, altri 20 soggetti a limitazioni per ragioni di sicurezza o assenza di collaudo, e un interramento che riduce drasticamente le capacità di accumulo.
Non è solo questione di perdite: la Corte sottolinea che molte concessioni per l’uso delle acque sono ancora regolate da canoni fissati vent’anni fa. Secondo Repubblica, per due dighe affidate a Enel a fini idroelettrici l’importo dovrebbe crescere di oltre il 500%, passando da 513 mila euro a 2,6 milioni. Ma il caso più emblematico riguarda proprio Siciliacque: sebbene applichi una tariffa agli utenti, non versa un euro di canone alla Regione. Una scelta che, in piena emergenza idrica, si traduce in un macroscopico regalo politico e finanziario a un privato che controlla il 75% della società. E tutto questo mentre, già nel 2023, l’Autorità di bacino aveva lanciato allarmi sulla siccità, rimasti senza interventi strutturali immediati.
Su questo scenario già critico si innesta la scelta politica più recente: puntare tutto sui dissalatori. Cento milioni per realizzarli, altri 67 per gestirli nei primi due anni, con fondi interamente pubblici. Beneficiario della commessa: Siciliacque, società mista controllata per il 75% da Italgas e per il 25% dalla Regione, che non tirerà fuori un euro di tasca propria. Il primo impianto, quello di Porto Empedocle, è partito solo in parte (ma dovrebbe garantire a breve l’immissione di 100 litri al secondo); quello di Gela dovrebbe avviarsi entro Ferragosto, Trapani a metà settembre. A pieno regime produrranno complessivamente 9 milioni di metri cubi l’anno: poco più del 2% dei 340 milioni che ogni anno – secondo Repubblica – si perdono nelle condotte siciliane.
E qui sta la questione politica. Perché l’operazione, al netto dell’indubbia utilità in situazioni di scarsità idrica, è costata (e costerà) molto più dell’acqua proveniente da fonti tradizionali: 1,70 euro a metro cubo, quasi il triplo dei 0,69 centesimi della rete. E secondo alcune stime, alla luce delle somme assegnate a Siciliacque, il costo effettivo potrebbe salire fino a 2,80 euro al metro cubo.
Il presidente Renato Schifani, intervistato da ‘La Sicilia’, ha difeso la scelta: «Sui dissalatori abbiamo puntato subito. Erano obsoleti, alcuni fermi da 14 anni. Adesso quello di Porto Empedocle è partito e da metà agosto garantirà 100 litri al secondo. Gela e Trapani entreranno presto a regime. E poi c’è la grande scommessa dei due dissalatori in project financing a Palermo. Queste opere, recuperando la quota potabile, consentono un circolo virtuoso riducendo il prelievo nelle dighe miste, che danno più acqua agli agricoltori. E stiamo lavorando sulla rete irrigua e sulla riduzione delle dispersioni. Quest’estate la crisi si è ridimensionata, dalla prossima ritengo che la fase emergenziale sarà conclusa».
Parole ottimistiche, che però stridono con i rilievi della Corte dei conti. Perché se l’acqua in Sicilia “c’è” – come ricordano i magistrati – il problema è che non arriva dove serve e se arriva si disperde. E non è una questione che si risolve in dodici mesi: la mappatura delle reti è ancora incompleta in molti Comuni e le condotte colabrodo restano la voragine più grande nei conti e nelle forniture. A ben vedere, la Sicilia affronta la siccità con troppe armi spuntate: dighe a mezzo servizio, perdite che divorano metà della risorsa, morosità endemica, una gestione frammentata fra undici diversi soggetti. Di recente, i franchi tiratori dell’Ars hanno affossato la riforma dei Consorzi di Bonifica, un provvedimento utile, secondo Schifani, a “rafforzare un comparto chiave dell’agricoltura siciliana e garantire una gestione più efficiente del territorio”. Anche le garanzie occupazionali per i lavoratori dei Consorzi sono state “impallinate” durante la discussione feroce sulla manovrina e rinviate a settembre. Così come non ha visto la luce la norma sulla realizzazione di 500 laghetti artificiali in funzione anti-siccità: per Luca Sammartino, fautore dell’articolo 11, è dipeso dalle solite “beghe politiche”.
La Regione, di fronte a un problema strutturale, ha scelto una soluzione di emergenza – i dissalatori – che divora risorse pubbliche e affida la gestione a un privato già in difficoltà, senza affrontare la vera voragine: quella delle condotte. La partita dell’acqua è politica prima ancora che tecnica. E oggi, nonostante le rassicurazioni di Palazzo d’Orléans, sembra ancora aperta.