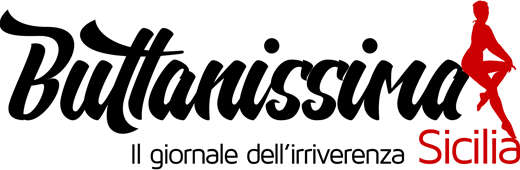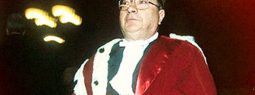Se il “Dio, Patria e Famiglia” tanto caro alla destra conservatrice italiana fosse declinato al plurale e al futuro? Dei, patrie e famiglie.
Perché il nostro Dio, per chi ci crede, non escluda quello in cui altri, legittimamente, credono; perché amare la propria patria significhi rispettare l’amore che altri provano per la loro, senza che questo diventi mai bieco nazionalismo o presunta superiorità, con l’idea, magari, che abbiamo tutti una sola Patria comune, questo pianeta, la nostra comunità; perché la famiglia “tradizionale” si è evoluta, mostrando — accanto ai suoi straordinari valori fondanti — anche le ipocrisie e le falsità che la minavano. Accettare, valorizzare, aiutare famiglie aperte, omosessuali, monogenitoriali è giusto, necessario e bello.
Se parlassimo al plurale, saremmo più capaci di condivisione, almeno di ascolto. Capiremmo che avere “la consapevolezza storica di ereditare una tradizione, una cultura, un’identità e un’appartenenza” (Meloni dixit) non significa trasformarle in un totem. Appartenere deve implicare accoglienza, condivisione, evoluzione. Ereditare significa creare nuovi valori, investire, guardare al futuro, comprendere l’evoluzione della società. Tradizione e appartenenza non devono essere valori su cui fondare una coscienza di clan, chiusa e autoreferenziale: l’ecclesia dei Greci e dei Cristiani era comunità di partecipazione e ascolto, non di esclusione.
Oggi, invece, la radicalizzazione del pensiero, da destra a sinistra, e la personalizzazione estrema della leadership politica, spesso priva di cultura, minano la sicurezza delle democrazie. L’incapacità di ascolto e la difesa cieca del proprio punto di vista generano mostri: dall’Ucraina alla Cisgiordania, fino alla grottesca “difesa dei confini” in Italia, trasformata in guerra tra uno Stato e individui disperati e disarmati che vengono da continenti e scenari di guerra che ci appartengono. Nel silenzio di chi sempre meno partecipa al voto.
E il cosiddetto “Centro”? In Sicilia discute della sopravvivenza politica di cinici leader quasi ottuagenari, interessati solo a mantenere il potere, ridotto a clientela: non risposta ai bisogni della società, ma ai favori dei singoli, specialmente se figli, figliocci, in qualche modo parenti della peggiore politica locale, basta che siano detentori o portavoce di detentori di pacchetti di voti e possibilmente non eletti e disoccupati. Altro che valori cristiani, solidarietà o dottrina sociale della Chiesa: parole svuotate di significato, archiviate come ideologie della Prima Repubblica.
Intanto destra e sinistra si inseguono nella perenne delegittimazione reciproca, sull’idea di una presunta supremazia culturale perduta o da conquistare, alimentando due religioni laiche che, spesso grottescamente, non disdegnano, per legittimarsi ancora di più, di far propri i principi, i simboli, i riti, i protagonisti, delle istituzioni religiose. Così, Papa Francesco, il Cardinal Zuppi, don Ciotti diventano “di sinistra”, mentre semplicemente vivono e predicano i valori del cattolicesimo che non ha aggettivazione politica.
I media digitali azzerano il confronto ed esasperano la propaganda e lo scontro, rendendoli rapidi e brutali: il ragionamento diventa slogan, la riflessione meme, la politica emozione immediata. Si citano, a sproposito e, spesso, senza averli mai ascoltati, Moro, Berlinguer, Craxi, addirittura De Gasperi, dimenticando che la loro forza era la complessità del pensiero radicato nella cultura politica, la capacità di parlare ore in Parlamento o in piazza, senza mai aizzare le folle contro alcuno dei loro avversari politici; che il loro modello di politica era la forza della riflessione e della comprensione dei bisogni sociali collettivi e la capacità di costruire architetture dello Stato capaci di rispondergli e che, forse, o probabilmente, oggi, non saprebbero affatto come agire in un sistema di comunicazione che rifiuta la complessità, che ritaglia frasi, avverbi, aggettivi da un discorso ampio, per farli diventare invettiva, accusa, capo di imputazione politica, costantemente indirizzato a colpire l’altro.
Leggere gli straordinari discorsi di Robert Kennedy durante la terribile campagna elettorale che lo portò alla morte, tenuti, non a caso e molto spesso, nelle Università americane e confrontarli con le idiozie balbettanti del figlio o con il “truth” di Trump, che già nel nome rivela arroganza e presunzione di essere la verità assoluta, mostra quanto si sia smarrita la politica come comunità di valori Non era mai successo, in Europa, in Occidente, dopo la seconda guerra mondiale che la violenza politica potesse nascere dal confronto politico istituzionale, da chi le istituzioni le rappresenta. Oggi, succede nella più grande delle democrazie occidentale, gli USA e, nel nostro Paese, la delegittimazione reciproca è moneta corrente, così come il reciproco accusarsi di fomentare l’odio politico. Cosa sarebbe mai successo, nel 1948, se così avessero ragionato Togliatti, Nenni, Saragat, De Gasperi, oppure Berlinguer e Andreotti o qualsiasi altro leader negli anni di piombo?
Piuttosto che alla filosofia politica, categoria ormai ottocentesca, si ricorre da una parte al Fantasy, con i buoni e i cattivissimi, la compagnia dell’anello contro Mordor e Saruman, mancano solo gli alberi parlanti, votati l’uno all’estinzione dell’altro; dall’altro si confonde Winston Churchill e la incredibile operazione Dynamo che liberò gli inglesi e i francesi assediati a Dunkerque, con la flottiglia di Greta Thumberg, tanto romantica, viva e potente sul piano mediatico quanto debole sul piano logistico e umanitario. Ma per tanti, si vince o si perde sul web, la realtà, poi si vedrà. Essere visibili conta più che essere concreti.
Ragionare per convincere, per creare una comunità di valori è ben diverso che lanciare slogan per creare dei gruppi di fanatico consenso, incapaci di vedere i valori altrui.
Dove è finita la politica? Come non rendersi conto che questa semplificazione, dal discorso al messaggio, questo continuo mostrare i muscoli fatti di parole discriminanti e senza appello, sta erodendo i valori fondativi non solo dell’Occidente, ma di qualsiasi società civile.
Si svuotano le chiese, si delegittimano le istituzioni dello Stato, perfino i Parlamenti e le Corti di Giustizia, si radicalizzano i pensieri religiosi, si sostituisce l’informazione con la comunicazione on line, si perdono i valori della convivenza: dalla comunità locale fino alle nazioni.
Torniamo allora a pensarci plurali: riscopriamo la bellezza della comprensione dei valori altrui, dell’arricchimento che nasce dalla complessità, dall’ibridazione culturale, sociale, persino etnica. Se non lo faremo, saremo perduti.