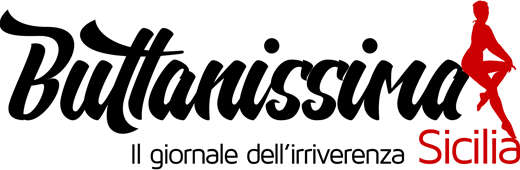Tutto ciò che contribuisce a tutelare la sicurezza dei cittadini di Palermo è utile, purché non si riduca solo a un esercizio di repressione. Le misure di controllo — zone rosse, DASPO, maggiore presenza delle forze dell’ordine, coordinamento più efficace — possono avere un effetto immediato, ma non bastano a cambiare le condizioni che generano la violenza.
I risultati ottenuti dal presidente della Regione e dal sindaco nell’incontro con il ministro dell’Interno potranno rassicurare, per un momento, chi vive nel centro della città. Ma restano soluzioni parziali, che agiscono sulla superficie del problema e rischiano di offrire alla politica un alibi di efficienza, senza incidere sulle cause profonde.
Il nodo vero è capire se i provvedimenti annunciati potranno servire anche allo ZEN e agli altri quartieri esclusi, dove la paura e la mancanza di prospettive alimentano la rabbia. Chi si farà carico di quel bambino di nove anni che minaccia il suo insegnante perché ha interiorizzato la violenza come linguaggio normale?
Schifani e Lagalla hanno il dovere di andare oltre la risposta d’emergenza e affrontare con coraggio il compito più difficile: elaborare un progetto di lungo periodo, capace di tenere insieme sicurezza e giustizia sociale. Sulla rete si invocano l’esercito, il muro di recinzione di alcune zone periferiche, persino la pena di morte. Sono reazioni istintive, dettate dalla paura. Ma la politica non dovrebbe alimentare e cavalcare la paura: dovrebbe trasformarla in responsabilità. Le scorciatoie securitarie non risolvono l’ingiustizia, l’abbandono, l’isolamento, non riescono certo a combattere né tanto meno a prevenire adeguatamente il crimine. Servono politiche pubbliche che restituiscano appartenenza e dignità.
Nella prossima visita a Roma, il presidente della Regione e il sindaco di Palermo dovrebbero incontrare non solo il ministro dell’Interno, ma anche quelli dell’Economia, dell’Istruzione e delle Infrastrutture, per ottenere un piano organico per le periferie: scuola a tempo pieno, asili nido, centri di aggregazione, lavoro e sostegno ai più fragili.
E dovrebbero cominciare col chiedere a Salvini di rinunciare al fantasma del ponte sullo Stretto, destinando le risorse alla riqualificazione urbana, alla ricucitura delle città.
Il sindaco deve intervenire sul degrado visibile — la pulizia, i servizi di base, il verde urbano — mentre la Regione dovrebbe evitare la polverizzazione clientelare della spesa per destinare i pochi fondi disponibili a interventi strutturali.
La politica siciliana ha il compito di tenere accesi i riflettori sulle aree dove più si concentrano disagio e illegalità, non per stigmatizzarle ma per ricucirle al resto della comunità. Serve un confronto con il governo nazionale sulla coesione, sull’istruzione, sul lavoro, sull’infanzia.
È necessario capire l’urgenza di ricomporre il rapporto tra frange di cittadini e lo Stato, individuato come un nemico da cui restare lontani o addirittura da combattere, anche in modo violento, come è successo poche ore fa con i carabinieri che assolvevano ai loro compiti allo Zen.
Anche la cosiddetta società civile deve capire la natura del problema davanti al quale si trova, abbandonare il ricorso a riferimenti comodi e datati, smettere per esempio di mettere in scena un’antimafia di maniera, rituale e autoreferenziale, che non riconosce le forme nuove della violenza. Capire che accanto alla mafia è nato e si è diffuso qualcosa di diverso, perfino di più complesso. Oggi la minaccia non è tanto o solo la mafia tradizionale, ridimensionata, privata dei suoi “capi”, ma la frattura tra i cittadini e le istituzioni, l’odio verso lo Stato percepito come nemico.
In questi giorni a Palermo è emerso il caso di quell’imprenditore antimafia – che non è, beninteso, dello ZEN – indagato per presunte illegalità. Prima di collocarlo sugli altari, sarebbe stato utile approfondirne la conoscenza. Io l’ho conosciuto quando ha iniziato dei lavori ad un mio familiare. Non li ha completati, ha avuto problemi con i suoi operai. Avrei potuto dire che non mi pareva avesse le caratteristiche proprie per assumere il ruolo di simbolo dell’antimafia.
Alla fine, per tornare alla questione dalla quale si è partiti, punire è necessario, ma non basta. Le sole scelte securitarie non riducono i reati, la permanenza di chi delinque nelle carceri così come sono, nel nostro Paese ha solo il senso di ciò che indicava Foucault, tenere chi delinque in un Panopticon per isolarlo, non consentirgli di veder fuori, ma di essere visto, sorvegliato e di dare serenità ai benpensanti.
La certezza della pena, che dev’essere assicurata, non deve coincidere con l’abbandono in luoghi di violenza, che trasformano la detenzione in una scuola del crimine.
Occorre una pena che conti, ma che includa percorsi di reinserimento e formazione.
Punire è facile: si butta la chiave, si guarda altrove e ci si acquieta la coscienza. Ricostruire, invece, è difficile — ma è l’unico modo per restituire alla città una speranza di futuro, ricomponendo il rapporto tra tutti i suoi quartieri, rendendo naturali lo scambio e le relazioni. Includendo.