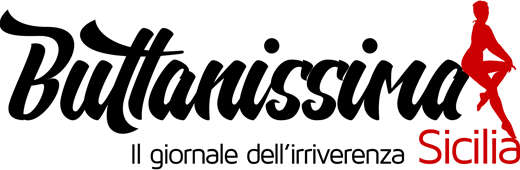Donne di Sicilia. Madri e figlie impilate come matrioske. In attesa, chissà, che venga il loro turno sul ponte di comando. E le zie. Ché non si può affrontare il tema del matriarcato o, quanto meno, del condizionamento femminile sulla letteratura e sulla società siciliana senza tirare in ballo le celeberrime zie di Leonardo Sciascia. Una sorta di triumvirato, Angela, Nica e Marietta. Lui le amò teneramente tutta la vita, memore del tempo e delle cure che gli avevano dedicato durante l’infanzia. E dell’educazione ricevuta, i cui dettagli “antifascisti” – si era negli anni Venti dell’Italia fascista – raccontò nel capitolo Breve cronaca del regime, quasi all’inizio del romanzo autobiografico Le parrocchie di Regalpetra, pubblicato nel 1956.
Certo, “lo scrittore è memoria”, diceva sempre Sciascia. Lo ripeté anche a me, nel periodo in cui capitava che prendessi un caffè con lui e la moglie Maria Andronico nel salottino liberty della casa di Palermo, il ritratto di Pirandello a campeggiare sulla scrivania come fosse il padre. Specificava, Sciascia, che “per ciascun individuo, i primi dieci anni di vita sono i più importanti, i più formativi. Si è, appunto, come si è stati nei primi dieci anni di vita. Contano quelle impressioni, quelle memorie. Soprattutto per uno scrittore”. La frase mi colpì e la inserii nel documentario: Il sogno della ragione. Appunti per un viaggio intorno a Sciascia, che realizzai nel 1992 per la Rai, l’azienda in cui lavoravo.
Memorie femminili, maternità e matriarcato sono le fila attorno a cui si dipana Corta è la memoria del cuore, il nuovo romanzo di Giuseppina Torregrossa. Di sé l’autrice dice “non sono una scrittrice, sono una cuntastorie”. Non deve essere un modo di dire se Torregrossa ha intitolato: Il mio cunto libero la lectio magistralis pronunciata in occasione del conferimento presso l’università di Palermo nel 2021 della laurea honoris causa in Italianistica.
In Corta è la memoria del cuore, appena pubblicato da Mondadori, Torregrossa – ginecologa palermitana e narratrice di successo da più di tre lustri – torna a esplorare identità femminili, inanellando questa volta quattro generazioni di madri e figlie. Una storia lunga cent’anni, dai silenzi cupi della sicilianissima matriarca Teresa alle voci limpide delle pronipoti Costanza e Viola, bambine “impastate di luce” e, forse, finalmente libere dagli astratti furori e dai concreti rancori che abitano “le femmine della famiglia Accoto”. Già il cognome Accoto, immediato nell’incipit del romanzo, sembra una dichiarazione di intenti, con quel suono duro come una schioppettata. E’ l’annuncio di un destino che trasformerà in rabbia “lo sguardo adorante e fiducioso” rivolto dalle figlie alle madri, generazione dopo generazione. “Corta è la memoria del cuore”, dice a se stessa la protagonista Elena Accoto, che tanto somiglia alla sua autrice. Quindi si immerge “in quell’acquario tiepido che risuona di un’unica parola ripetuta all’infinito: mamma, mamma, mamma”.
Le memorie infantili di Leonardo ruotavano, piuttosto, attorno alle zie Sciascia. Con la mamma non aveva confidenza. Furono le sorelle del padre, ad accogliere il piccolo, due anni appena, quando dovette lasciare la casa d’origine e la mamma al fratellino Giuseppe, nato nel 1923. I genitori lo portarono dal nonno. “Era paralitico: lo ricordo seduto vicino al balcone, il bastone in mano che gli serviva per chiamare, battendolo a terra con impazienza”. Le zie accorrevano per accudirlo. “Lo ammiravano al tempo stesso che lo consideravano uno stupido”, scrive Sciascia. “Stupido a essere onesto, cocciuto e incorruttibile”. Leonardo, a cui evidentemente non faceva difetto l’arte di coltivare un pensiero autonomo, si rese ben presto conto di essere, invece, orgoglioso dell’omonimo nonno. Orgoglioso proprio per la sua integrità.
Col nonno di Leonardo Sciascia, Teresa Accoto, la capostipite della genealogia femminile di Corta è la memoria del cuore di Giuseppina Torregrossa, ha in comune solo il bastone. Divenuta vecchia, lo usa per chiamare, battendolo a terra tirannica. Più che per camminare, le serve per minacciare chi le viene a tiro, soprattutto cammarere e animali di casa, gatti o cani. Il puntale brandito per rafforzare gli anatemi che lancia. Ché è dotata di un singolare talento femminile, sicilianamente chiamato “occhio pesante”. Cioè, un occhio carico di premonizioni oscure riguardo al futuro, con capacità congenita di scrutare nell’animo altrui e di evocare disgrazie che puntualmente si avverano. “Il suo occhio pesante – scrive Torregrossa – negli anni era diventato un automatismo”.
Teresa è colta, intelligente, ha conseguito una brillante laurea in Giurisprudenza come l’affascinante marito Luigi che ha conosciuto proprio all’università di Palermo. Ma vive nel contesto opprimente degli anni Cinquanta. “Era donna, chi l’avrebbe presa sul serio?”, scrive Torregrossa. I sogni dell’infanzia, il desiderio di possedere qualcosa, che fosse un libro, o un cappotto, sempre frustrato dal padre tanto benestante quanto tirchio, indirizzano le scelte di Teresa. “Lei aveva scartato i nati ricchi e con la strada spianata, non voleva sentirsi inferiore. Preferiva gli ambiziosi, affamati di riconoscimento, senza soldi e umiliati, che facevano carriera più dei figli di papà”. Con queste premesse interiori, Teresa baratta una possibile autonomia lavorativa con la decisione di restare a casa. Lì sarà “capofamiglia”. Sa che in un mondo di carriere maschili, l’unico luogo dove può comandare davvero è a casa propria. Non sarà “l’angelo del focolare”. Si farà consegnare dal marito tutto ciò che guadagna per amministrarlo lei. E farà pesare su tutta la famiglia la sua fatica, il fardello di crescere i figli. Un ricatto morale che è un modo molto siciliano di esercitare il potere. Alzando il prezzo per esercitare ancora più potere. Una recriminazione continua in cui l’onnivora matriarca si fa vittima. Per non pagare mai dazio.
Il piccolo Nanà – vezzeggiativo che Leonardo si portò appresso tutta la vita – a casa delle zie osservava e apprendeva. Dalle parole e dai silenzi. Bastava un cenno col dito per farlo zittire davanti al ritratto di Matteotti nascosto nel “paniere del cucito” da Angela, la maggiore delle zie. Poteva, invece, sbizzarrirsi quanto voleva col dirigibile di carta, un gioco sul modello di quello della spedizione Nobile del 1928 al Polo Nord. Lui ricorda nitidamente che lo ritagliava da solo in una stanza, mentre in quella accanto il nonno moriva alla presenza di tutti i familiari.
Le zie, dunque, erano la sua finestra aperta sul mondo, molto al di là dell’angolo remoto di Sicilia in cui abitavano: Racalmuto, provincia di Agrigento, borgo di braccianti, salinari e zolfatari. Era già un privilegio per Nanà Sciascia essere libero dal bisogno in un paese in cui i carusi morivano di fame. Poi, c’era Marietta, la più giovane delle zie. Era maestra. Aveva una biblioteca e poteva offrire libri al nipotino che si andava rivelando un lettore compulsivo. A Nanà non piaceva andare a lezione, ma con la zia imparò a leggere I promessi sposi prima ancora di frequentare la scuola.
A Teresa Accoto piaceva studiare. “In terza ginnasio aveva perfino ricevuto i complimenti di Ada Negri per un tema che la sua professoressa aveva inviato alla grande poeta”. La quale poeta, per inciso, fu l’unica donna ammessa all’Accademia d’Italia, prima che la fascistissima istituzione chiudesse i battenti con la caduta di Mussolini. Teresa Accoto, che viveva in un paesello desolato dell’entroterra siciliano, “si esprimeva in buon italiano, scriveva senza errori”. Eppure, “il silenzio fu la sua arma più efficace”. E poiché “certi caratteri sono custoditi per sempre nel DNA mitocondriale”, quello che si trasmette solo per via materna, nel romanzo di Torregrossa l’arte di tacere domina sulla “memoria del cuore”. Elena Accoto cresce nel silenzio, in una casa che nel lessico familiare viene denominata “Casa del Silenzio” (e tanto ricorda La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca, preludio nei rintocchi a morte e, soprattutto, nei silenzi della tragica frattura della Guerra civile spagnola).
Deve lottare, Elena, per conquistare le parole. Ne capisce la forza e il potere evocativo. Sa che in principio era il Verbo. Si commuove, infine, quando sente le nipotine Costanza e Viola pronunciare per intero la parola “mamma” e non il monosillabo “mà” in uso alla discendenza femminile della famiglia Accoto.
Visse sempre circondato da donne, Leonardo Sciascia, l’ultimo grande autore civile del Novecento, lo scrittore “coscienza critica” per eccellenza della società italiana e siciliana in particolare. Ebbe moglie, maestra come lui, e due figlie: Laura e Anna Maria. E’ proprio Anna Maria, fonte inesauribile di aneddoti su questo padre “così normale, così speciale”, a ricordare quando a Caltanissetta negli anni Sessanta vivevano con le zie Angela, Nica e Marietta. Sei donne nella stessa casa insieme con Leonardo Sciascia. Il quale non aveva mai nulla da ridire. Anzi. “dava un ruolo a ciascuna di noi, amando ciascuna per quello che era”. Anna Maria racconta di come a suo padre piacesse invitare amici alla sua tavola e sapesse cucinare per tutti. Come atto d’amore.
Nonostante le premesse, Sciascia come autore delineò personaggi femminili marginali. Le donne nei suoi romanzi rimangono sullo sfondo. A Franca Leosini che lo intervistò per L’Espresso nel 1974, Leonardo Sciascia spiegò “la ragione profonda” di questa scelta con l’avversione per la società matriarcale. Con il fatto che in Sicilia “ho visto sempre che le donne hanno comandato, e hanno comandato sempre annientando l’uomo”. E’ lei, la donna, a consigliare “la viltà, la prudenza, l’opportunismo, l’interesse particolare” all’uomo. Il quale obbedisce sempre. E aggiungeva, Sciascia, “in fondo questa virilità siciliana si riduce a ben poco, Brancati l’ha messo in luce impareggiabilmente”. La Sicilia, dunque, come matriarcato. Un matriarcato tenace, “molto nascosto e molto subdolo”.
Nel lungo video che ho realizzato alla Rai, Sciascia afferma, l’immancabile sigaretta tra le dita: “Mi conforta il fatto che uno scrittore straniero, un osservatore perspicace della realtà siciliana come Dominique Fernandez, abbia visto anche la mafia collegata a questo impero della donna. Io non arrivo a tanto, ma ritengo che l’uomo abbia cercato nella mafia come una famiglia in cui contare, mentre nella famiglia propria contava poco”. Basta e avanza, come giudizio. Anche senza aggiungere il carico di Dominique Fernandez, il quale in Madre mediterranea, un resoconto di viaggio nel Mezzogiorno d’Italia pubblicato nel 1965, aveva ipotizzato che gli italiani fossero “tutti figli di mamma” e che i peggiori difetti del nostro paese, mammismo e mafia inclusi, derivassero dal matriarcato,
L’intervista di Sciascia all’Espresso provocò un vespaio. Si capisce. Erano anni in cui il movimento femminista si faceva sentire, eccome. Matrimonio, lavoro, maternità; l’intero sistema su cui si reggeva la società italiana, e non solo, veniva messo in discussione. La riforma del diritto di famiglia che sanciva l’uguaglianza giuridica tra coniugi doveva ancora essere approvata, l’interruzione volontaria di gravidanza era reato.
Giuseppina Torregrossa era ragazza negli anni Settanta. Per di più studiava medicina e voleva occuparsi del corpo delle donne, il sancta sanctorum della femminilità. Non è un caso che abbia sempre scritto di donne. “Scrivere è un atto politico. E’ uno strumento di emancipazione, di resistenza”, dice. Ed è una curiosa parabola questa che lega la saga matriarcale di Corta è la memoria del cuore alla mistica della femminilità de Il conto delle minne, il romanzo, tradotto in dieci lingue, che la consacrò al successo nel 2009.
Per fare un esempio di una grande matriarca della narrativa siciliana, Leonardo Sciascia cita I Vicerè di Federico de Roberto. Il romanzo intorno alla famiglia dei prìncipi di Francalanza, discendenti di Vicerè della Corona di Spagna, “si apre che Teresa Uzeda è appena morta”, dice Sciascia. “Ma tutti i destini dei figli saranno dominati e determinati dalla volontà di questa madre, da questo terribile personaggio assente”.
Nel romanzo di Torregrossa la matriarca Teresa Accoto è viva e vegeta, benché quasi centenaria. Sarà la suggestione del nome di battesimo, ma è certo che l’incipit de I Vicerè le calza a pennello.