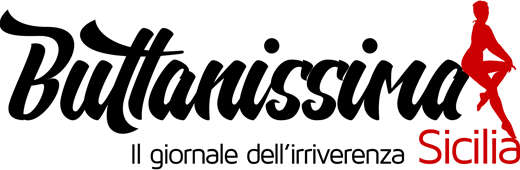Questo libro apre una finestra sullo stato delle arti tipografiche a Palermo, legate soprattutto alla produzione libraria ed alla informazione, dal 1800 al 1900. Dietro ad una qualsiasi stampa di questa epoca, come di altre, ci stanno non solo gli autori, ma gli uomini e qualche donna, che si impegnarono con alterna bravura e con passione alla crescita di una città, che in quegli anni offriva una poco invidiabile quantità di analfabeti.
La carenza di materiale documentario sulla vita di queste officine (spesso a conduzione familiare) e l’impossibilità di accedere alle emeroteche cittadine, ancora oggi “sequestrate” (quella della Biblioteca Comunale di Palermo da circa 30 anni), ci consente nella maggior parte dei casi di conoscere soltanto i nomi degli operatori ed il periodo in cui furono attivi; anche dei più noti possediamo lacerti di notizie, in molti casi difficilmente verificabili.
Per la raccolta dei dati abbiamo fatto ricorso alla diretta consultazione di libri, di schedari di biblioteche, di alcuni repertori a stampa o digitalizzati, svolgendo ostinate ricerche nei principali archivi cittadini.
I primi decenni descrivono il passaggio dai tipografi-artigiani alle nuove generazioni, impegnate a strutturare meglio le officine, accedendo tiepidamente a nuove tecniche di stampa e facendo uso più ampio di illustrazioni. In questo periodo era presente un vivace commercio clandestino, che favoriva l’ingresso di libri e gazzette provenienti dal resto d’Europa (soprattutto Francia e Inghilterra) e d’Italia su argomenti politici, filosofici, letterali e scientifici. Il rischioso espediente serviva non solo per evitare onerosi dazi, ma soprattutto per sfuggire all’occhiuta censura borbonica che, per mezzo di scelti revisori, decideva su tutte le pubblicazioni.
La rivolta del ’48 rappresentò un momento alto per la stampa e la diffusione di materiale; i comitati rivoluzionari si erano prefissi il compito di fornire accurate informazioni sulle decisioni del governo e consentire con maggiore libertà l’accesso a pubblicazioni “fuori regno”. La successiva restaurazione fu dura! Diversi tipografi finirono nelle galere, altri fuggirono in esilio nel Nord Italia continuando il loro lavoro negli stabilimenti piemontesi e lombardi, consentendo loro in alcuni casi di apprendere tecnologie all’avanguardia, per i tempi.
In epoca post unitaria, quando le nuove aggregazioni politico-culturali si delinearono (come abbiamo appreso nelle carte di polizia) veri e propri schieramenti: nostalgici dei Borboni, cattolici “retrivi” e più numerosi quelli che si erano aggregati ai Savoia; si comprende meglio come molti esponenti delle correnti patriottiche, che avevano corso maggiori rischi, erano state in gran parte emarginate.
Un aspetto non trascurabile ed economicamente vitale è quello relativo alle forniture di stampati alle pubbliche amministrazioni laiche ed ecclesiastiche, monopolizzato dai più attrezzati e ricchi stabilimenti tipografici.
Tanto nelle piccole che nelle grandi tipografie si dovevano affrontare ciclicamente altre difficoltà, dovute alla scarsezza di cartiere, di fonditori di caratteri e la mancanza di buoni inchiostri (importati dalla Germania). Malgrado tutto si affermarono nella seconda metà dell’Ottocento eccellenti tipografi-editori palermitani che, in virtù dell’ampio bagaglio culturale dei conduttori e buona conoscenza del mercato, avrebbero riscosso successi notevoli in tutto il paese: Sandron, Pedone Lauriel e Biondo.
Un tassello importante di questa storia è dedicato al sorgere delle associazioni di editori e tipografi ed alle prime lotte sindacali della categoria. Ancora nelle carte della prefettura emerge la difficile e talvolta pericolosa attività sindacale che, allo scadere del secolo, a Palermo conobbe importanti momenti di aggregazioni per rivendicazioni salariali e per sollecitare migliori condizioni di lavoro da parte dei padroni.