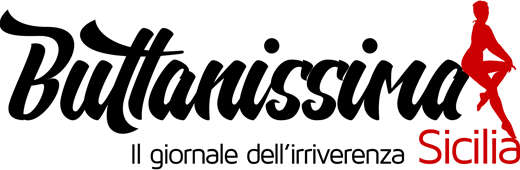La visita della Commissione regionale antimafia allo ZEN può rivelarsi utile. Può segnalare l’attenzione delle istituzioni per una zona della città dalla quale sono venuti gli autori dei più recenti episodi di efferata criminalità e dove marginalità ed enormi problemi sociali contribuiscono a generare violenza.
Può servire una seduta “aperta alla cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni, per aiutare lo ZEN a reagire”, come ha detto Antonello Cracolici. Al netto di qualche evidente nota populista, è opportuno che si esca dal “Palazzo” per andare nei luoghi del malessere, per far sapere ai suoi abitanti che non sono soli, che si ascoltano le voci di chi vive in un contesto nel quale il legame tra loro e lo Stato, se mai è esistito, è diventato esile al punto da apparire inesistente.
È sempre giusto far emergere sul campo le questioni più gravi ed urgenti. Tutto bene se non vi fosse il rischio che la visita della Commissione si trasformi in una “passerella”, in un gesto autoconsolatorio che tacita la coscienza di chi lo compie, anche se mosso dalla consapevolezza di esercitare il proprio ruolo.
Ma a proposito di ruolo, la visita può consolidare un fraintendimento, alimentare la stucchevole narrazione di un’antimafia di maniera, che mette insieme la stessa mafia e tutti i problemi dello ZEN, dei tanti ZEN delle periferie e dello stesso centro della città. Potrebbe far ritenere che ci si trovi ancora di fronte ad una realtà inalterata dai tempi di Falcone e Borsellino e che risulti pertanto opportuno battere una scorciatoia molto più agevole e meno ardua che nel passato e che tuttavia conferisce ancora status, regala lustrini, fa ottenere citazioni sui mezzi di informazione.
E insieme devia. Distrae da ciò che da tempo è presente e che sta assumendo forme pericolose, creando incertezza e paura sempre maggiori, magari cinicamente utilizzate per la ricerca del consenso.
Cracolici e i componenti della Commissione allo ZEN si troveranno per qualche ora in un quartiere dove la mafia esiste non più che in altre zone della città, dove trova manovalanza perché lì vivono migliaia di persone alle quali lo Stato, la Regione e il comune da sempre risultano estranei e lontani.
Quel quartiere del resto è stato creato apposta per segregare, ghettizzare, isolare, per rimanere avulso e sconosciuto dal resto dei palermitani, da quella parte della sua borghesia che magari lo percepisce attraverso il fornitore di “fumo” o di altro e che può continuare a considerarsi diversa, perfino migliore di quei giovani che la riforniscono e che “godono” di più del 79% di disoccupazione, che vivono in mezzo al degrado ambientale con appena l’1,7% di spazi verdi, che sono privi di servizi minimamente civili, che hanno potuto ottenere un livello culturale ed educativo bassissimo.
Ma al di là del “fumo”, Palermo non vuol sapere nulla dello Zen e con crescente fastidio delega quella realtà alle forze dell’ordine, chiedendo di continuare a rafforzare il muro della separatezza e può sentirsi soddisfatta se qualcuno spiega che la causa dei problemi di quella realtà è la mafia, quella che giornalisti, intellettuali, se ancora ce ne sono, magistrati ed ex magistrati con insistenza denunciano, ignorando tuttavia la trasformazione che la stessa ha avuto, i colpi che ha subito, i successi ottenuti dalle forze dello Stato in una battaglia lunga e sanguinosa.
Ignorano tutto ciò per tenere in vita un totem inalterato che moltiplica il valore dell’impegno e della denuncia, un totem che – sia detto a scanso di equivoci – non può essere ignorato, semmai considerato per quello che realmente è. Un racconto insistito e spesso di facciata ha deviato l’attenzione da ciò che è successo nel nostro tessuto sociale, dalla sua progressiva lacerazione, dalla perdita di senso di comunità. Cracolici è una persona intelligente e conosce la realtà di Palermo. Eviterà la passerella, la ripetizione del consueto racconto e utilizzerà l’iniziativa – è augurabile – per tentare di far sapere ai governi di Palermo e di Roma e al suo stesso partito ciò che avrà sentito allo ZEN (ché se poi andasse a Brancaccio non troverebbe molta differenza). Potrà indicare le questioni vere, che non sono quelle proprie della sua Commissione di indagine che, detto senza alcuna polemica, può apparire poco più di un centro studi. Potrà dire a Schifani, a Lagalla e a Piantedosi che i ventiquattro poliziotti inviati a Palermo e la istituzione delle zone rosse non hanno reso né potranno rendere la città più sicura. Quella dell’ordine è di fatto una questione reale che va affrontata con mezzi adeguati, non ricorrendo ai pannicelli caldi e sfuggendo alla tentazione di una militarizzazione impossibile, buona per un annuncio forte e vigoroso di Meloni e Salvini, ma che, del tutto inefficace, scansa ciò che realmente esiste nelle nostre città e nelle nostre periferie. La militarizzazione, oltre ad essere contraria alle regole della democrazia, rischia che chi non rispetta la legalità si senta sfidato ad una guerra impropria, indotto pertanto a difendere il proprio territorio e il proprio modello di vita. Ed è il cambiamento radicale del modello di vita delle nostre periferie che dovrebbe impegnare la politica, la scuola, i corpi intermedi, le associazioni per tendere ad una realtà più omogenea e solidale nelle nostre città. Lo Stato, per farsi rispettare, per ottenere la coesione sociale, deve presentarsi con il rigore delle proprie leggi ma principalmente con l’autorevolezza che si ottiene solo da un rinnovato patto sociale con i suoi cittadini.