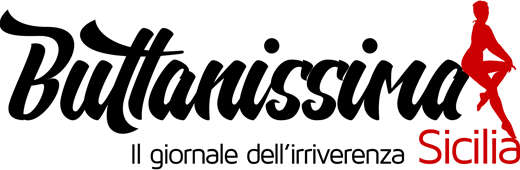Quando la notizia della morte di Alice ed Ellen Kessler, icone dello spettacolo europeo del dopoguerra, ha iniziato a circolare, l’attenzione si è spostata quasi subito sul contesto in cui il decesso è avvenuto. Le gemelle, 89 anni, hanno scelto il suicidio assistito: una procedura che in Germania, in assenza di una legge specifica ma in forza di una sentenza della Corte costituzionale, può svolgersi in modo discreto e privato. Così il caso ha riaperto il confronto tra Paesi che regolano il fine vita in modi differenti.
Sul territorio tedesco, dicevamo, il suicidio assistito è stato depenalizzato nel 2020, quando la Corte costituzionale federale ha dichiarato incostituzionale la norma che lo vietava. In assenza di una cornice legislativa, l’accesso alla procedura si è strutturato attraverso l’attività di associazioni come la Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS), Sterbehilfe e Dignitas Deutschland. Queste realtà possono intervenire purché la persona richiedente dimostri di agire responsabilmente e di propria spontanea volontà, di essere maggiorenne e di avere piena capacità giuridica. L’intero percorso si sviluppa all’interno del rapporto diretto tra il richiedente e i professionisti coinvolti, senza una valutazione preliminare da parte dello Stato. Ma l’assistenza si limita alla preparazione del farmaco, mentre l’atto finale deve essere compiuto dalla persona stessa, poiché l’intervento diretto di terzi configurerebbe eutanasia attiva, che rimane proibita.
Il racconto fornito da Wega Wetzel, portavoce della DGHS, ricostruisce l’iter seguito dalle sorelle Kessler. “Con loro c’erano un medico e un avvocato. Hanno fatto una prova tecnica con la soluzione salina. Poi ci siamo accertati un’ultima volta della loro libera e responsabile decisione. A quel punto hanno girato la valvola”. Wetzel sottolinea che il medico provvede alla preparazione dell’infusione, mentre il gesto finale deve essere compiuto dalla persona interessata. Il coinvolgimento delle autorità avviene solo dopo la constatazione del decesso.
In Italia il quadro è diverso. L’eutanasia resta illegale e configura reato; è invece possibile accedere al suicidio medicalmente assistito, ma solo alle condizioni definite dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso di Antoniani Fabiano (noto come Dj Fabo), che ha individuato il perimetro entro cui l’aiuto al suicidio non è punibile. La persona deve essere pienamente capace di intendere e volere, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze considerate intollerabili e dipendente da trattamenti di sostegno vitale. L’intero percorso è pubblico: la richiesta va presentata alla Asl competente, che istituisce una commissione medica multidisciplinare e trasmette il fascicolo al comitato etico territorialmente competente per un parere non vincolante. Una volta concluso questo procedimento, il richiedente può decidere se e quando accedere alla procedura.
I dati riflettono la diversa impostazione dei sistemi. In Germania, dove i suicidi assistiti non compaiono nelle statistiche ufficiali, sono le associazioni a diffondere le loro rilevazioni: 137 casi comunicati nel 2020, 359 nel 2022, 615 nel 2023. Le stime del 2024, invece, parlano di circa 1.200 casi seguiti da operatori specializzati e oltre 200 procedure assistite da singoli medici. Il numero di suicidi assistiti da persone senza formazione sanitaria non è noto. Parallelamente, le statistiche nazionali registrano per il 2023 un totale di 10.304 suicidi, con un aumento significativo dei decessi causati da farmaci, una categoria in cui potrebbero rientrare anche alcuni casi di suicidio assistito non segnalati.
In Italia, negli ultimi dodici mesi il servizio informativo Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni ha ricevuto 16.035 richieste di informazioni legate al fine vita, pari a 44 contatti al giorno e con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Più di 1.700 richieste riguardavano eutanasia e suicidio medicalmente assistito, mentre 580 persone hanno chiesto informazioni sulle procedure italiane o sui percorsi esteri. Dal 2020 sono state censite almeno 51 richieste formali di accesso alla procedura, un dato parziale raccolto attraverso richieste di accesso civico alle Regioni; 15 persone hanno ottenuto l’autorizzazione e 10 hanno portato a termine la procedura in Italia.
La raccolta dei dati regionali restituisce un quadro disomogeneo. Alcune Regioni hanno fornito informazioni dettagliate, altre hanno risposto in modo incompleto o non hanno risposto affatto. “Manca trasparenza e uniformità nella gestione delle richieste di verifica delle condizioni per poter procedere con il suicidio medicalmente assistito come previsto dalla sentenza della Consulta. La tutela dell’autodeterminazione non può essere rimessa all’arbitrio delle singole ATS o all’inerzia politica”, hanno commentato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. E aggiungono: “Il numero di persone morte prima del completamento dell’iter dimostra come servano procedure e tempi certi”.
Alcune Regioni, però, hanno iniziato a muoversi autonomamente. Nel febbraio 2025 la Toscana è stata la prima a approvare una legge sul fine vita, definita in conformità alla sentenza della Corte costituzionale del 2019 e promossa dall’Associazione Coscioni. Il provvedimento stabilisce tempi e modalità entro cui il servizio sanitario deve rispondere all’istanza del malato. La Sardegna, nel settembre 2025, ha varato una legge che prevede l’assistenza sanitaria gratuita per le persone affette da patologia irreversibile e dipendenti da trattamenti vitali che scelgono di accedere autonomamente al suicidio medicalmente assistito.
Dal confronto tra Germania e Italia, in definitiva, emergono modelli costruiti su presupposti distinti: nel primo caso l’accesso al suicidio assistito avviene in un contesto privato, mediato da associazioni e da verifiche dirette sulla volontà della persona; nel secondo, la procedura è incardinata nelle strutture pubbliche e scandita da controlli istituzionali. Due impostazioni normative che riflettono tradizioni giuridiche differenti e continuano a orientare il dibattito europeo sul fine vita.