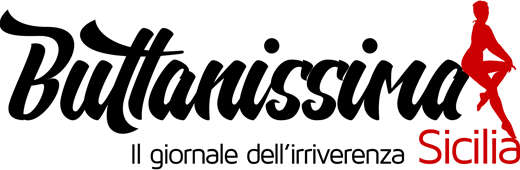È finito anche questa volta come in un derby con le tifoserie delle curve ad urlare e ingiuriarsi.
È finito con la memoria di Falcone lacerata dallo scontro per una sorta di esclusiva del suo patrimonio morale.
Come in vita, ancora oggi, a trentatré anni dalla sua morte, su di lui ci si divide in modo perfino pretestuoso e banale. Le polemiche, le accuse, gli scontri, prendono il luogo della speranza di costruire una memoria condivisa.
Venerdì scorso vi sono stati due diversi modi di ricordare Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta vittime della strage di Capaci.
Un corteo della antimafia sociale e “intersezionale” – così si sono definiti i partecipanti ricorrendo ad una locuzione difficile e inconsueta, con la quale un sociologo americano indicò un insieme di situazioni e vicende diverse e non facilmente componibili -, ha percorso alcune delle vie centrali di Palermo nella direzione dell’“Albero”.
Tanti ragazzi, di sicuro in buona fede, ché l’ingenuità non rende sempre consapevoli dei cattivi maestri, hanno gridato slogan dissimili su questioni tutte rilevanti: la Palestina, il riarmo, il ponte di Messina, la mancanza del lavoro, il governo della destra, la mafia e la sua permanente pericolosità.
Un’altra manifestazione ha visto i rappresentanti delle istituzioni con Maria Falcone e Pietro Grasso.
Quando si è deciso di far suonare il “silenzio” dieci minuti prima dell’ora della strage, mentre il corteo non era ancora arrivato, la contestazione ha cambiato verso. Ha scelto come bersagli la sorella del magistrato e Grasso, che nel maxiprocesso aveva svolto il ruolo di giudice a latere, era stato procuratore della Repubblica a Palermo, capo della direzione nazionale antimafia e infine presidente del Senato.
Le scuse, il riconoscimento dell’errore non hanno attenuato lo scontro, non hanno spento l’indignazione dei ragazzi, che avrebbero voluto partecipare alla conclusione dell’evento, continuando naturalmente a manifestare dissenso e a gridare slogan. Alcuni poi, non più giovani e di conseguenza senza la stessa freschezza e ingenuità, hanno colto l’occasione per creare o approfondire fratture, deviando l’attenzione dal patrimonio morale di Falcone alla tromba del militare che ha suonato il silenzio in anticipo.
A quel punto ha preso corpo una protesta in larga parte incomprensibile che ha dato l’impressione di richiamare i fantasmi di un lontano passato, quando egli era costante bersaglio di sospetti, di accuse, di una vera e propria campagna di delegittimazione.
Sono tornati ad aleggiare quei fantasmi, provocando ulteriori divisioni, allargando fossati, impedendo che sulla memoria degli eroi civili si crei un consenso vasto, si realizzi una larga unione di intenti che, isolando i mafiosi e i loro complici, continui il percorso allora segnato, che i criminali pensarono di potere interrompere con il tritolo.
È tornato Orlando, sempre in prima fila, qualunque sia la direzione della fila, a dar vita ad uno scontro duro con Maria Falcone. L’ex sindaco di Palermo non ha creduto, naturalmente, che il silenzio anticipato sia stato un errore, né ha preso per buone le scuse di Grasso e si è fatto carico del desiderio legittimo dei giovani manifestanti di conoscere tutta la verità sulla strage di Capaci al di là delle risultanze processuali. E non c’è dubbio che la ricerca storica, su quella e su altre vicende, potrebbe fare emergere ambiguità che permangono ed eliminare zone d’ombra forse mai del tutto illuminate.
Nessuna ulteriore indagine può aggiungere o togliere nulla all’ostilità di Orlando nei confronti di Falcone, quando al ministero di Giustizia metteva a punto gli strumenti che consentiranno allo Stato di cambiare verso nei confronti della criminalità organizzata.
Tutto aveva avuto inizio dopo che un trafficante di droga, detenuto nel carcere di Alessandria e più volte visitato da esponenti della “primavera di Palermo”, al pubblico ministero aveva dichiarato che il mandante dell’assassinio di Piersanti Mattarella era stato Salvo Lima e che l’ordine di uccidere Dalla Chiesa era partito da molto in alto, da “un personaggio della Democrazia cristiana”.
Si era vicini, scrisse a quel tempo L’Unità, quotidiano del Partito comunista, “alla verità pericolosa che può squarciare il sipario che sino ad ora ha nascosto gli assassini di Palermo”.
Appena Falcone interrogò Pellegriti, capì subito di trovarsi di fronte ad un falsificatore e lo incriminò per calunnia. Sfumò in quella circostanza la via giudiziaria alla modifica dell’assetto politico e al magistrato non venne risparmiata l’accusa di voler salvare Lima ed accreditarsi nei confronti di Andreotti, impaurito, si aggiunse, per il fallito attentato dell’Addaura.
Il sindaco della “primavera” accusò inoltre Falcone di tenere dentro “i cassetti del Palazzo di Giustizia” le risultanze che avrebbero fatto “chiarezza sui delitti Mattarella, La Torre, Insalaco e Bonsignore”, costringendolo a rendere conto del suo operato al Consiglio superiore della Magistratura. Quando poi egli lasciò il tribunale di Palermo per la direzione degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia, sempre Orlando sostenne che andava via “senza aver firmato nessuna delle istruttorie dei delitti politico-mafiosi, lasciando così un buco nero”.
Dopo tanti anni, avrebbe potuto riconciliarsi con la memoria di Falcone. Così pare non sia stato, se la sorella del giudice lo accusa di incoerenza, di essere stato “uno dei peggiori nemici di Giovanni Falcone” e gli chiede “un silenzio totale. Dignitoso. Dovuto”.
“Sventurata la terra che ha bisogno di eroi”, scrisse Brecht. Ancora più sventurata quella terra che non riesce a creare una memoria comune sui suoi eroi e la espone a scontri e polemiche che si ripetono in modo anche stucchevole e incomprensibile.